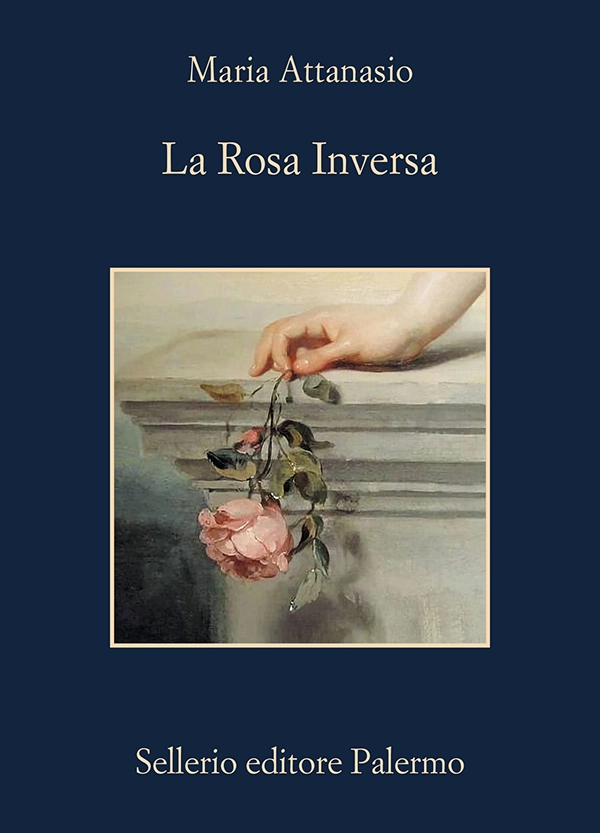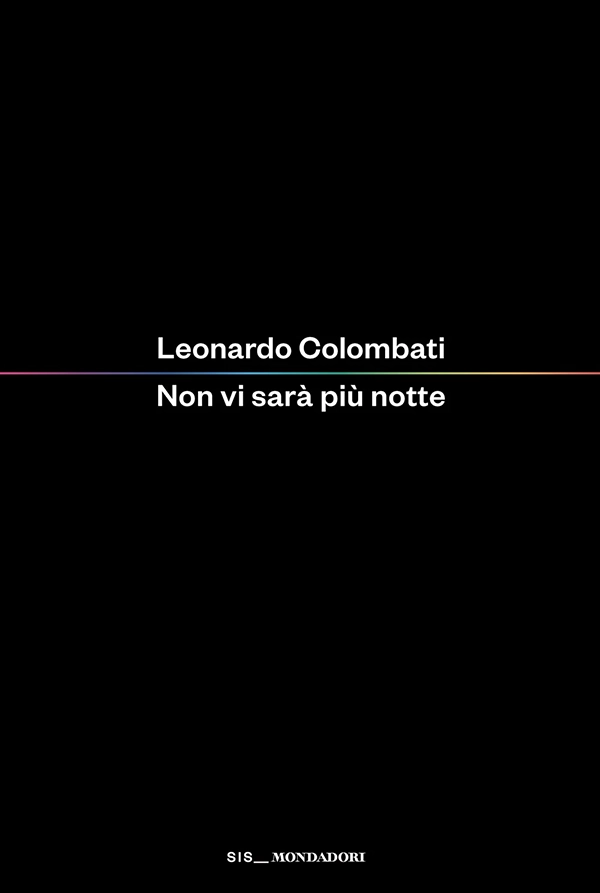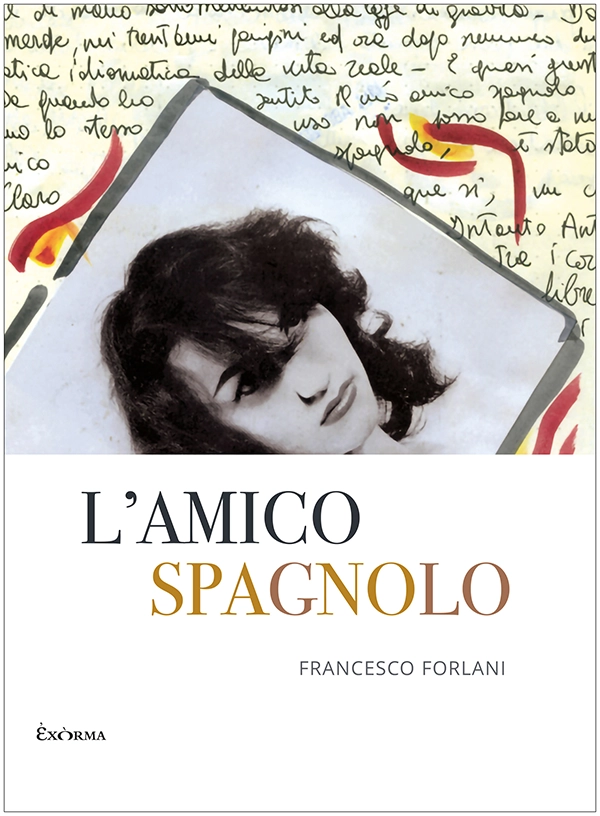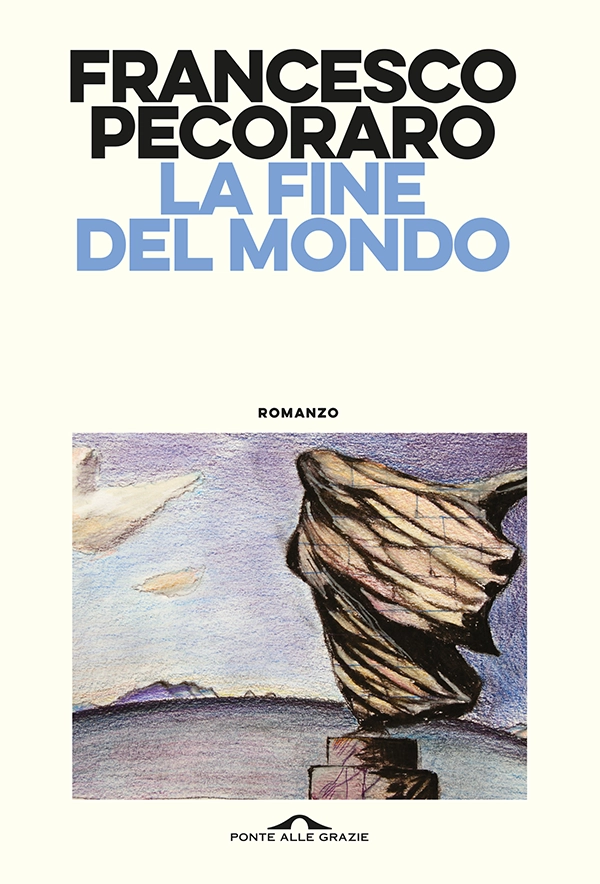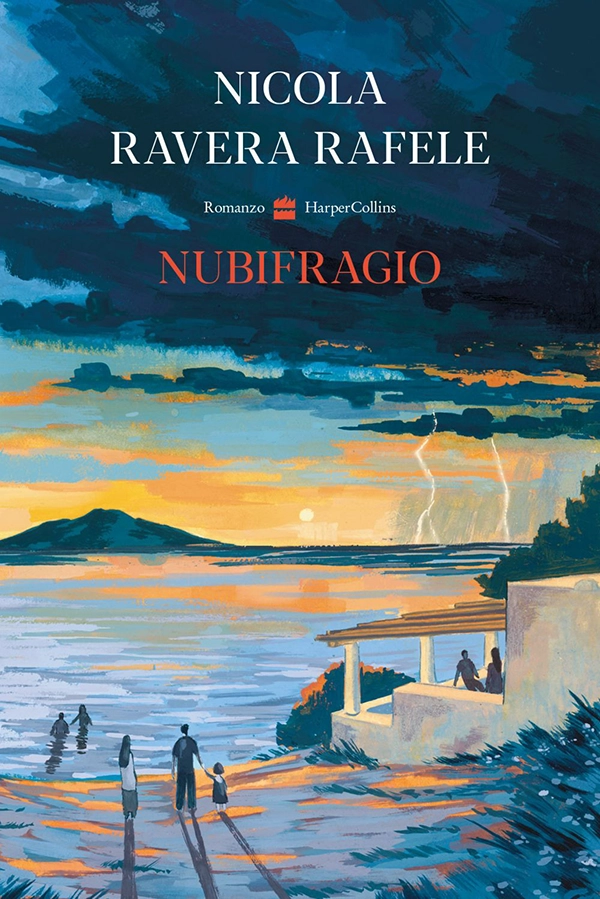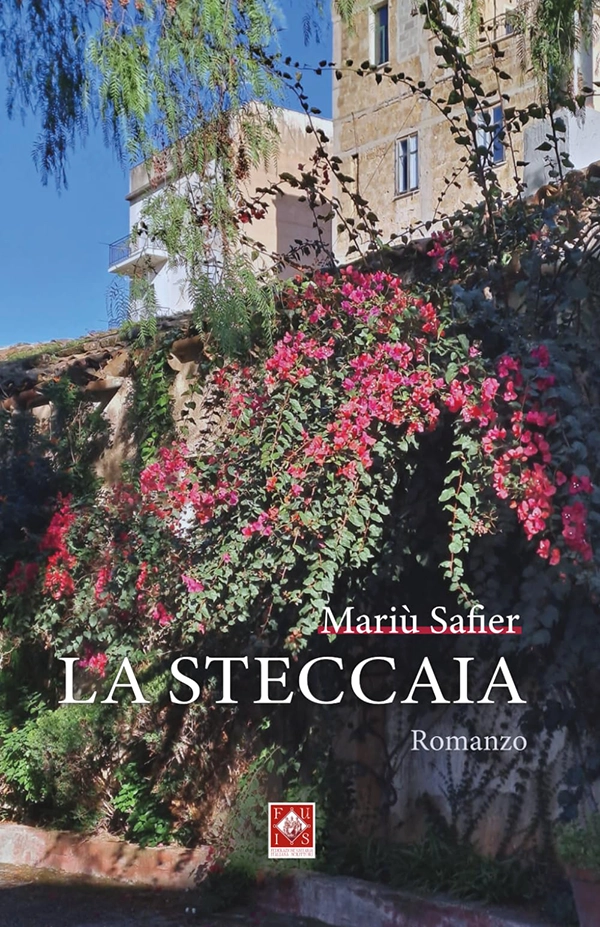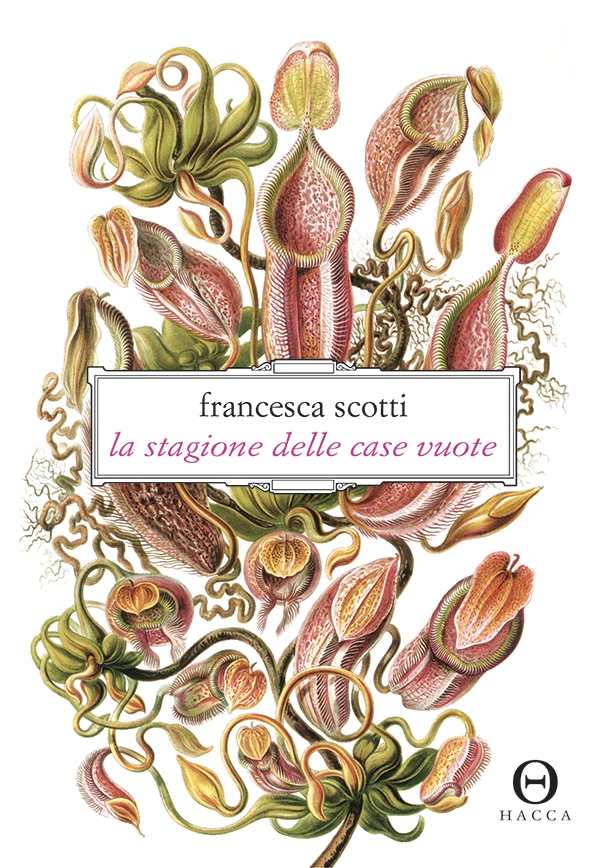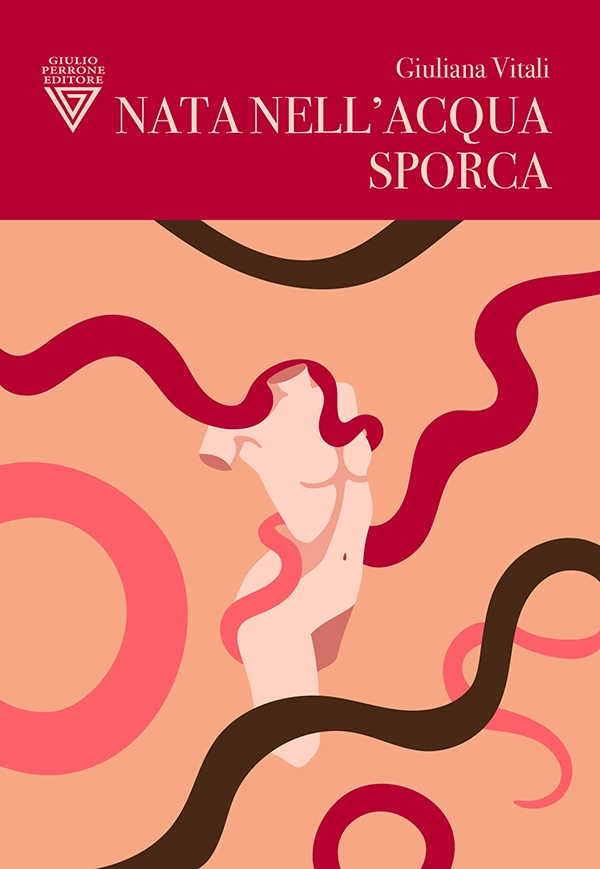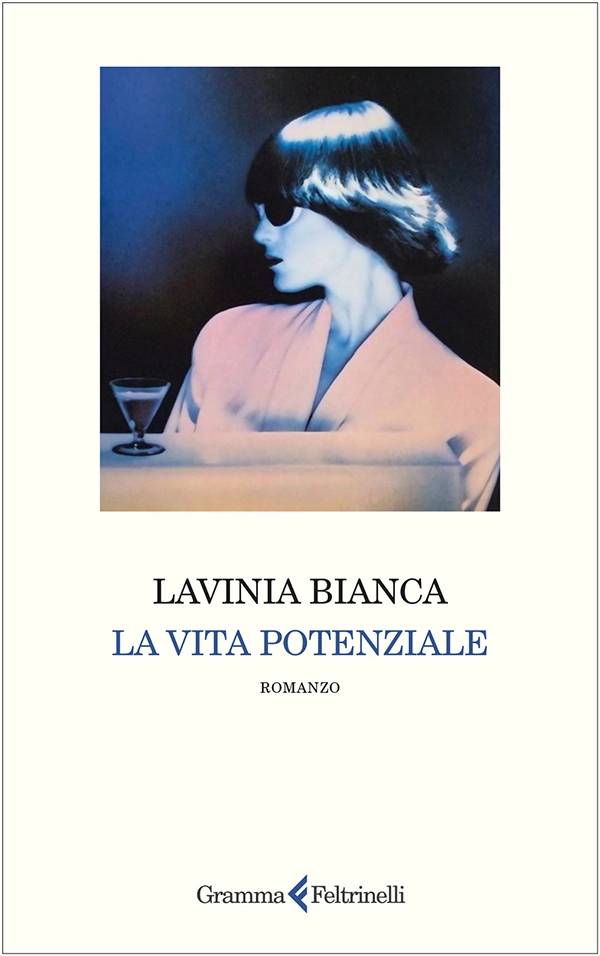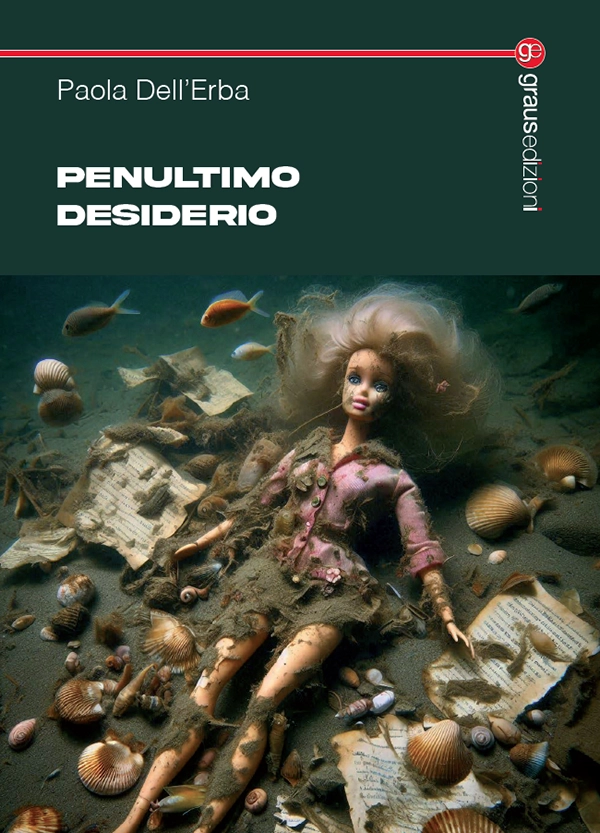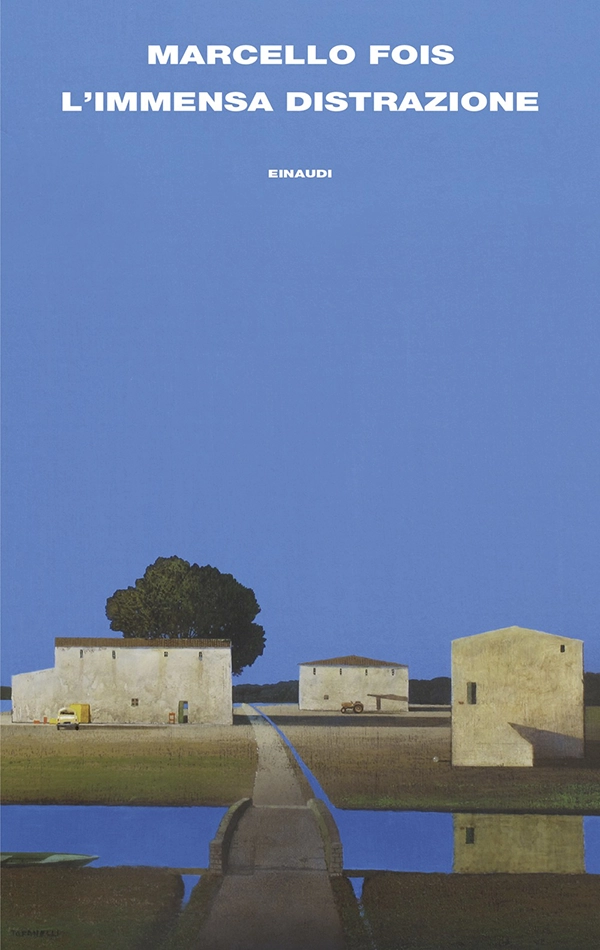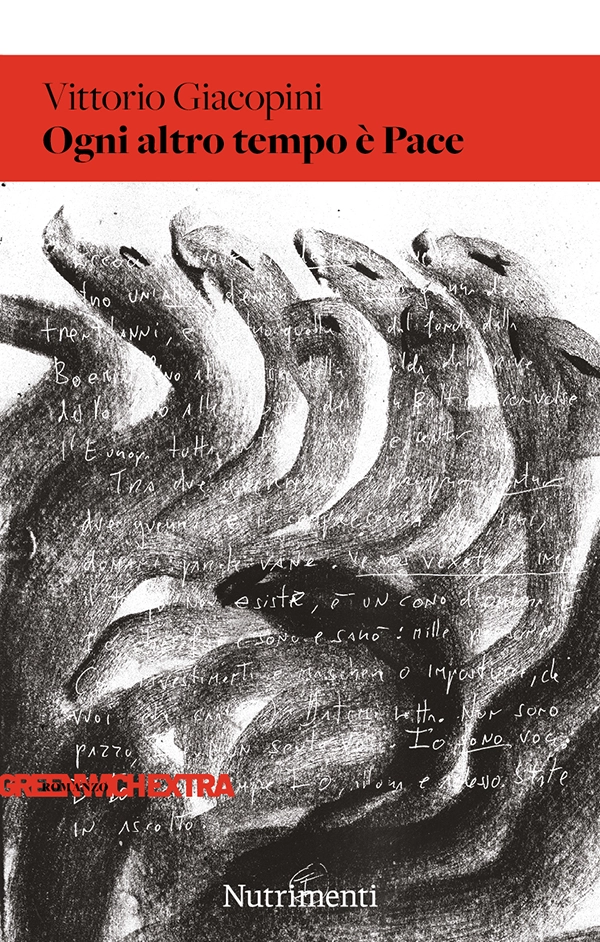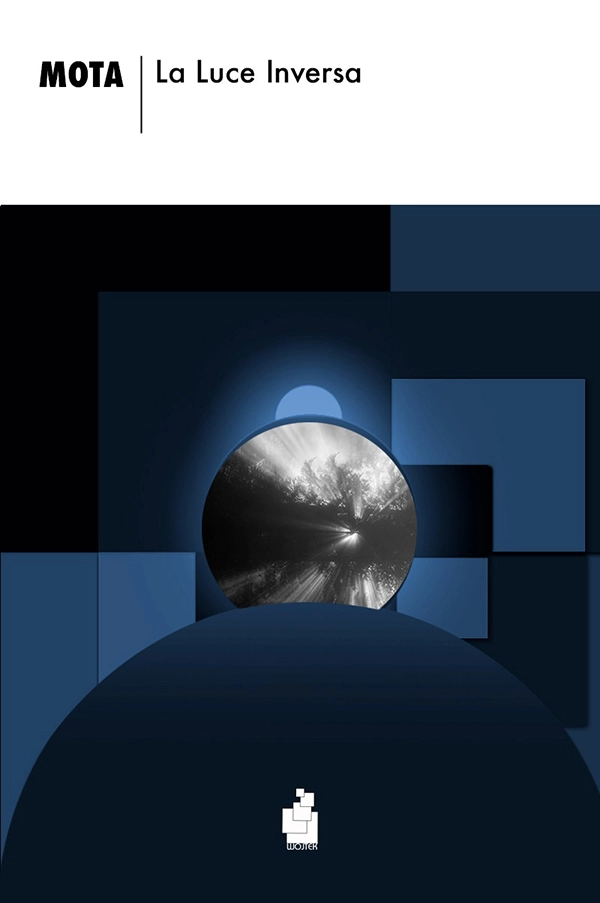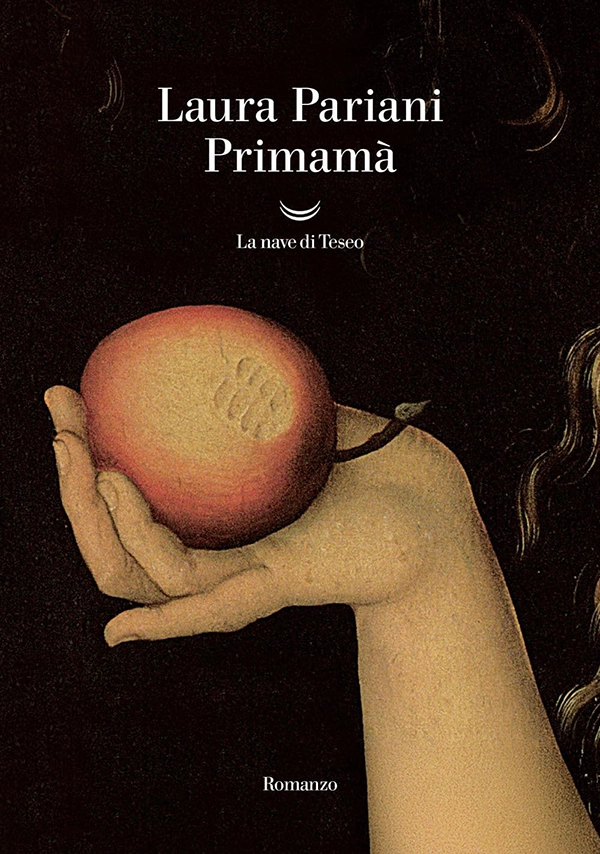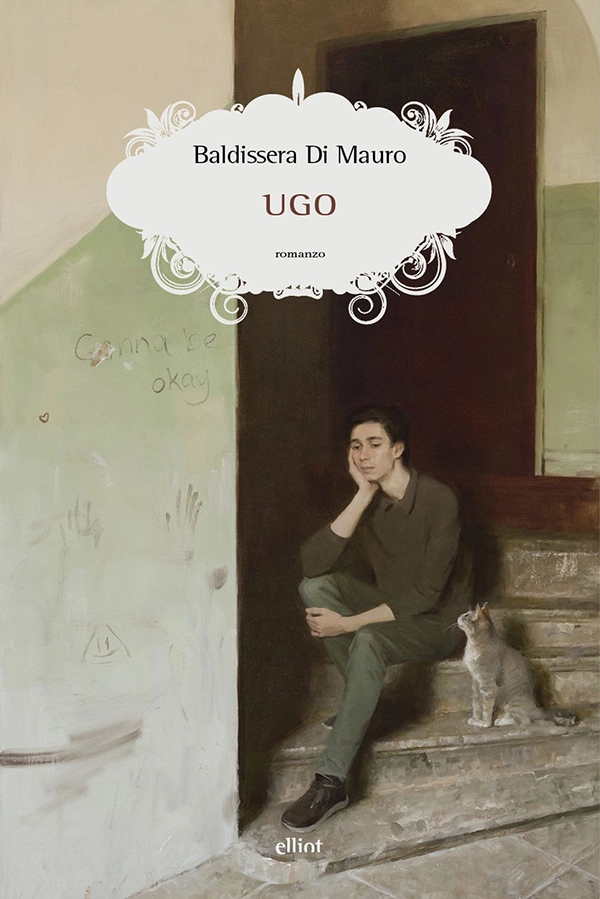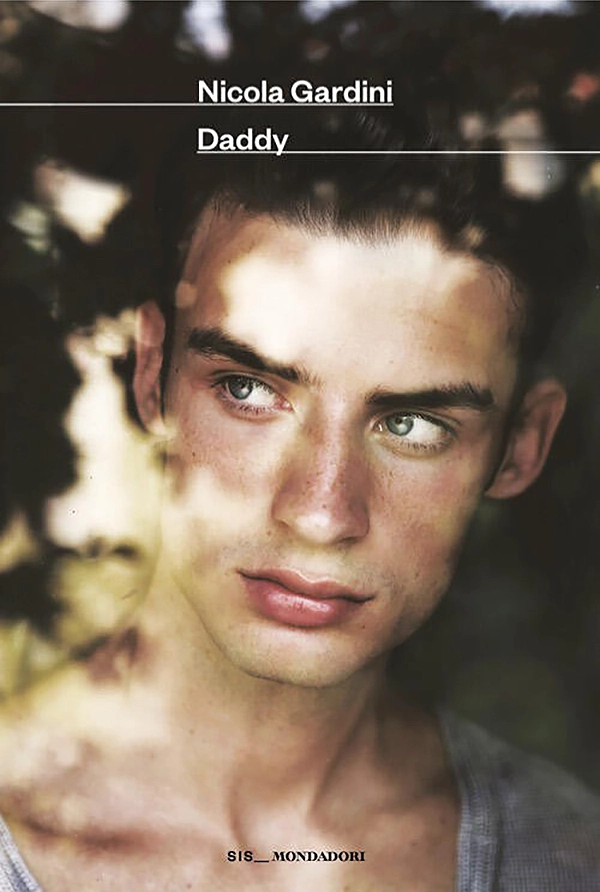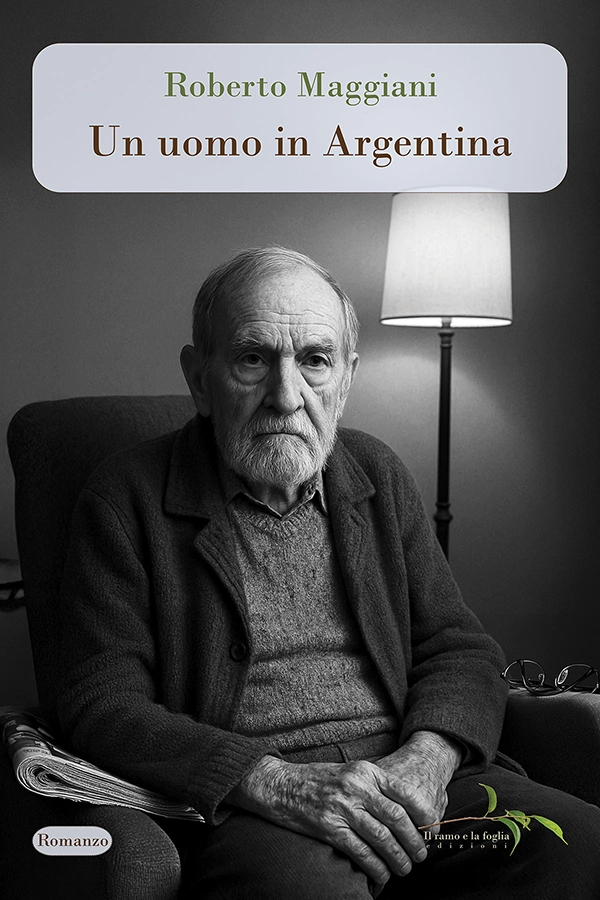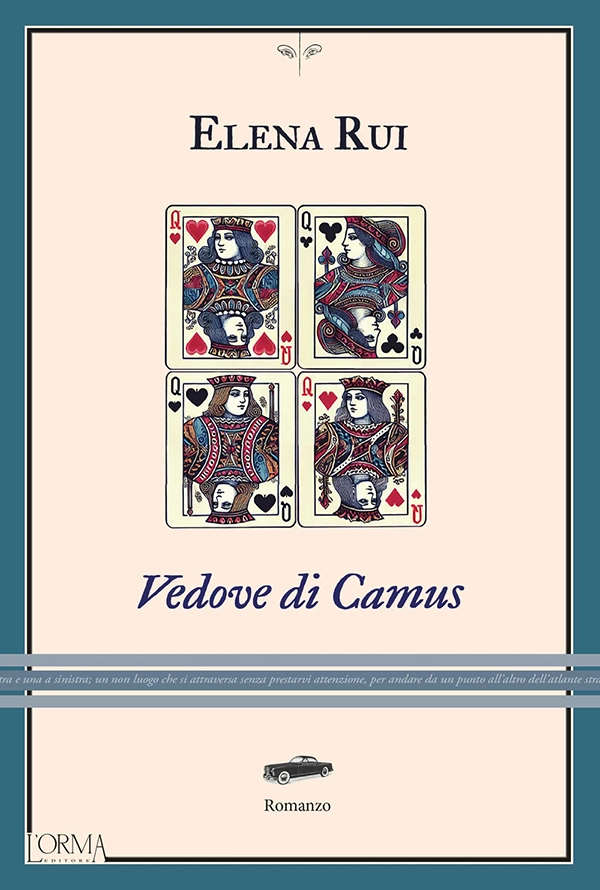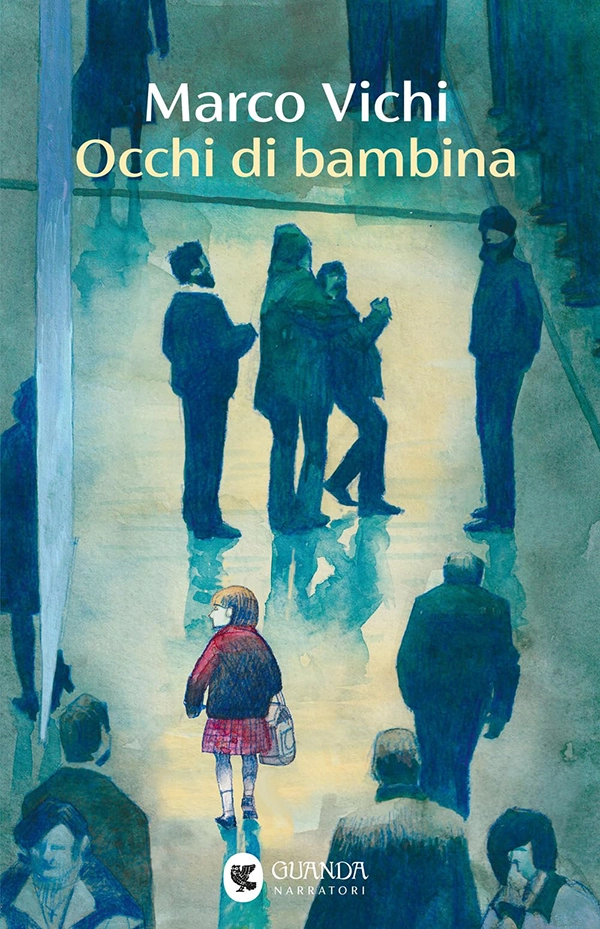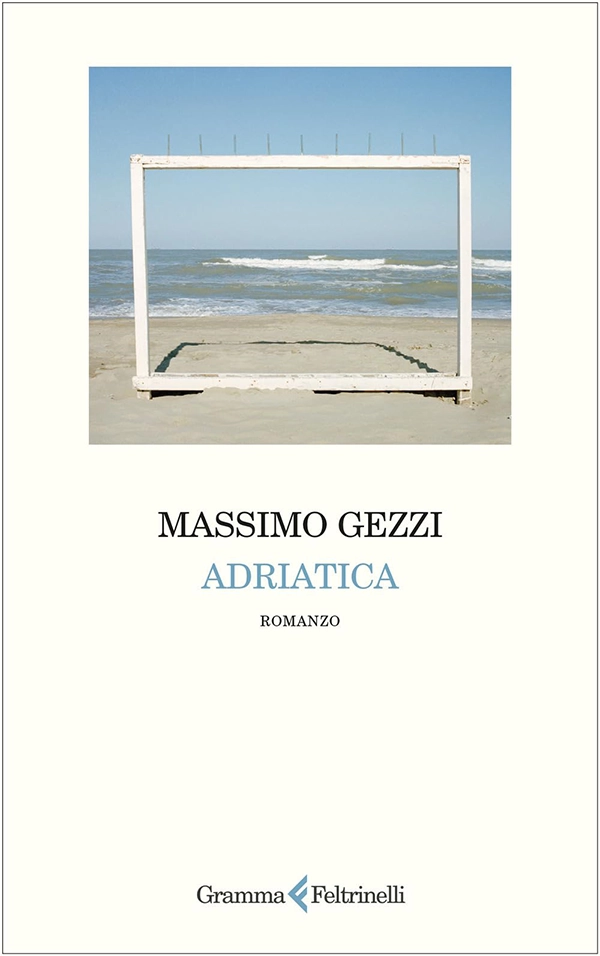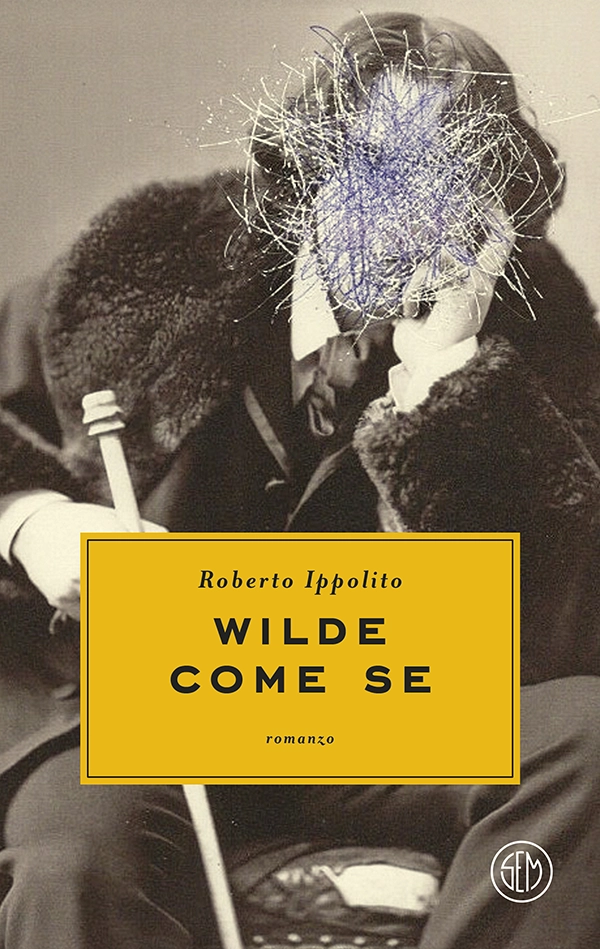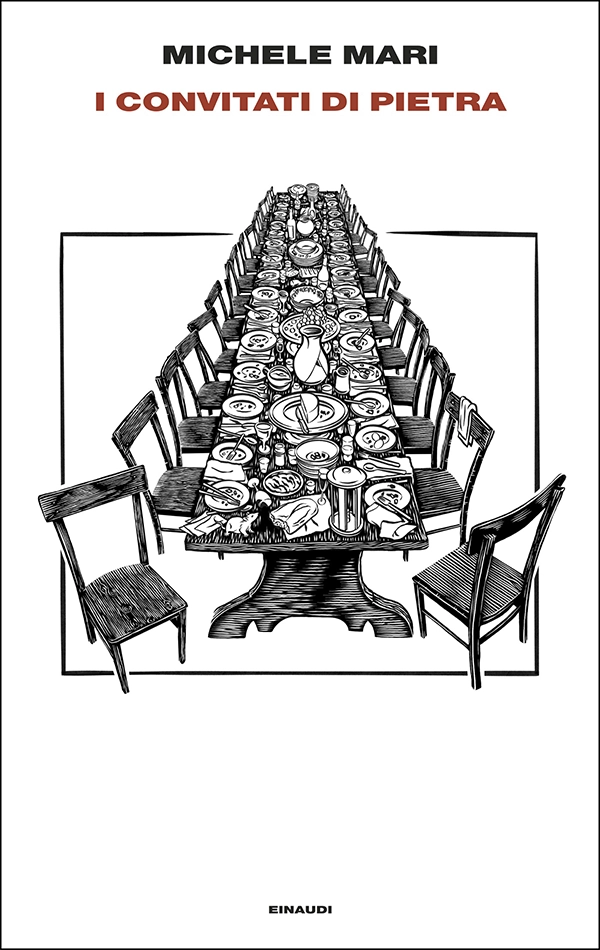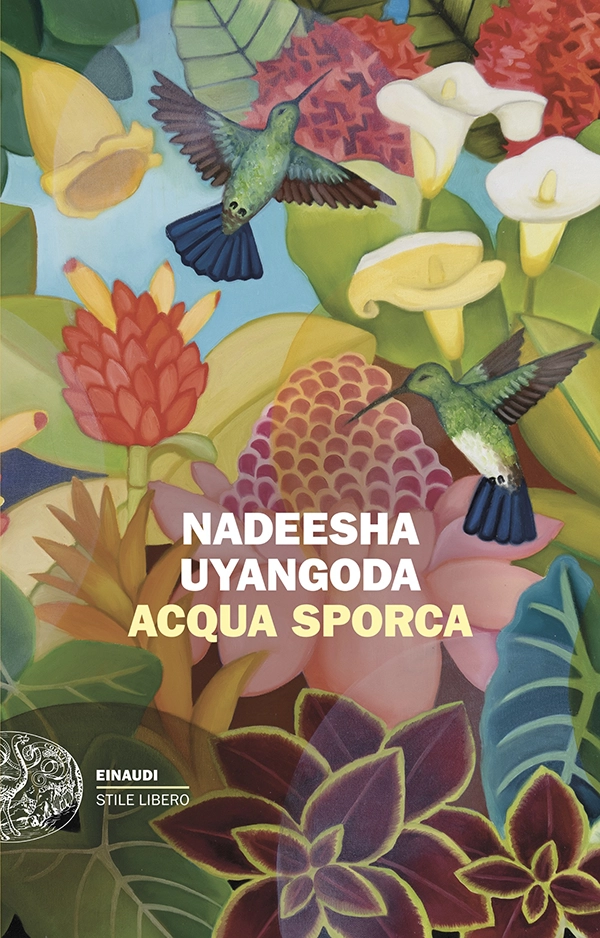Quarto gruppo, 2 marzo 2026
Davide Bregola
Lezioni dalle rovine (Leggere, scrivere, vivere)
Avagliano
Proposto da: Emanuele Trevi
Gianluigi Schiavon
Parlami morte. Il libro segreto dell’Archiginnasio
Giraldi Editore
Proposto da: Simonetta Bartolini
Terzo gruppo, 24 febbraio 2026
Enrico Bruschi
Riflessi inversi. Nella mente di Mariù Pascoli
Maschietto Editore
Proposto da: Maria Concetta Mattei
Bruno Damini
Il primo a prender fuoco fu Totò. La Grande Storia di monsù Peppino cuoco errante
Minerva Edizioni
Proposto da: Roberto Barbolini
Secondo gruppo, 17 febbraio 2026
Giulia Lombezzi
L’estate che ho ucciso mio nonno
Bollati Boringhieri
Proposto da: Alessandra Tedesco
Primo gruppo, 10 febbraio 2026
Cosimo Damiano Damato
Nessuna grazia. Gramsci e Pertini, una storia di prigionia e resistenza
Rai Libri
Proposto da: Raffaele Nigro